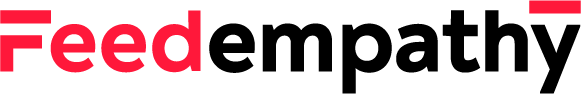Empatia: istruzioni per l’uso
– Nicola Quadri
Cos’è e come può aiutarci a costruire una società migliore
Empatia è una parola ingombrante e complessa. È usata moltissimo, eppure è poco conosciuta. Ha tanti significati solo in apparenza simili tra loro, sia nel linguaggio comune sia in quello scientifico. Come se non bastasse, è una parola che non si limita a esprimere un concetto, ma veicola una visione del futuro, etica e politica: un auspicio.
Non a caso ci ripetiamo che serve più empatia – nel mondo del lavoro, negli ospedali, nella politica, nella società civile – e che coltivare la nostra empatia verso gli altri può renderci persone migliori, perché più solidali e più giuste.
Ma davvero una società più empatica è una società con meno sofferenza e più solidarietà? Di quale empatia – tra le tante – stiamo parlando? E se è così, come possiamo coltivarla?
Un problema di definizione: cos’è l’empatia?
Quando la usiamo nel linguaggio parlato, non facciamo molte sottigliezze e distinzioni: in genere la descriviamo come la capacità di “mettersi nelle scarpe di qualcun altro”, ma in realtà il termine empatia – così come questa intuitiva definizione – è più ambiguo del previsto.
Può essere utilizzato per indicare la capacità di provare le stesse emozioni che sta provando un’altra persona (una sorta di contagio emotivo, seppur controllato), oppure la capacità di comprendere le emozioni di un’altra persona (senza quindi necessariamente condividerle), o ancora la capacità di assumere la prospettiva di un’altra persona, il punto di vista che è in grado spiegarne scelte ed emozioni. A volte viene usato in modo ancora più generico, come la volontà di aiutare chi ci è vicino e di alleviarne le pene.
C’è chi ritiene – come il famoso primatologo Frans de Waal – che questi diversi fenomeni debbano avere lo stesso termine, perché sono espressioni via via più complesse e stratificate di una stessa esigenza evolutiva: quella di capire e sentirsi vicini agli altri, così da potersi aiutare a vicenda. In linea con questa visione l’empatia si presenta – come la ricerca etologica ha ampiamente dimostrato – anche nel mondo animale, ma in diverse gradazioni e sfumature. Si parte dalle forme più “istintive” e semplici di empatia (le più vicine al contagio emotivo: sento quello che stai sentendo tu) e si arriva fino a quelle più complesse e cognitive (capire la prospettiva di altre persone, o addirittura il loro modo di fare esperienza della realtà: capisco come ti senti, quello che pensi), alcune delle quali sono esibite solo dai primati o da noi Homo Sapiens. Del resto siamo gli unici sul pianeta a empatizzare con personaggi inventati, oggetti inanimati e opere d’arte.
Nel tentativo di ridurre questa confusione terminologica, una minoranza di scienziati – come lo psicologo Paul Bloom dell’Università di Yale – preferiscono restringere la definizione di empatia alla condivisione dello stato emotivo, usando invece il termine compassione per indicare la capacità di comprendere lo stato emotivo di qualcuno – e prendersene cura, se necessario – senza però farne esperienza. Cercando di rendere più profondo il solco intorno a questa scelta lessicale, Paul Bloom ha anche scritto un libro dal titolo provocatorio “Contro l’empatia. In difesa della compassione razionale”. Ma cosa si può avere contro l’empatia? O meglio, contro la sua espressione più emotiva?
Stare vicini all’altro, ma dalla giusta distanza
Al netto delle scelte lessicali, che sono sempre arbitrarie, Bloom non ha tutti i torti: secondo le ultime ricerche in ambito psicologico e neuroscientifico non tutte le forme di empatia hanno effetti positivi e alcune, paradossalmente, potrebbero allontanarci dagli altri invece che avvicinarci.
La chiave sta proprio nel coinvolgimento emotivo. Se empatizzare con qualcuno che sta soffrendo significa condividerne – anche se solo in parte – la sofferenza, il risultato potrebbe essere il contrario di quello auspicato: invece di avere le risorse psicologiche ed emotive per essere d’aiuto, l’esperienza della sofferenza produce affaticamento e stress e può anzi allontanarci. Questo è specialmente vero se si tratta di una condizione prolungata nel tempo, come accade per certe categorie professionali, come i medici o gli psicologi, e nei casi peggiori può condurre a un vero e proprio burn out.
Al contrario, riuscire a empatizzare con l’altro nel senso di comprendere le sue emozioni e prendersene cura ma senza farne a propria volta esperienza, sembra la chiave non solo per avvicinarci agli altri e renderci più altruisti e attenti, ma anche – come dimostrano gli esperimenti – per ricaricare le nostre energie, migliorare il nostro umore e ridurre il nostro livello di stress, innescando così un circolo virtuoso.
Allenare la propria empatia
Questa capacità di comprensione e di vicinanza distaccata – senza cioè lasciarsi travolgere dall’emotività dell’altro – può e anzi deve essere coltivata, perché si tratta di un prodotto culturale molto più che biologico.
È vero: ci siamo adattati, nel corso dell’evoluzione, per essere empatici, ma soprattutto nel senso di saperci sintonizzare sulle emozioni degli altri individui del nostro gruppo, un fenomeno che gli scienziati hanno osservato in animali diversissimi tra loro, dai ratti ai primati non umani, passando per i cani e i cetacei.
Tuttavia i limiti di questa “empatia innata” non sono pochi. Innanzitutto in essa il ruolo più importante è giocato dal coinvolgimento emotivo (che è la forma probabilmente più antica, evolutivamente parlando). E poi c’è il problema di che cosa consideriamo all’interno del “nostro gruppo”. Perché per chi sta fuori spesso e volentieri la biologia smette di esserci di aiuto. La distinzione tra “noi” e “loro” infatti, per quanto odiosa, è presente virtualmente in ogni società umana e in ogni specie animale: questa sì, è un bel regalo dell’evoluzione biologica.
Per fortuna noi esseri umani abbiamo una straordinaria flessibilità quando si tratta di tracciare i confini di queste categorie, che non solo cambiano da cultura a cultura ma che possono modificarsi nel corso del tempo con più facilità di quanto pensiamo. Ecco perché è possibile lavorare sulla nostra capacità empatica: come società, attraverso la cultura e politica, per allargare i confini del “noi” e come singoli, per imparare a comprendere gli altri e provare compassione per loro senza lasciarci travolgere da sentimenti vicari, che rischiano di renderci meno disponibili.
Diversi studi – molti condotti dalla neuroscienziata Tania Singer del Max Planck Institute di Lipsia, che è considerata una delle massime esperte di empatia – ci dicono che esercitarsi tutti i giorni leggendo le espressioni degli altri e interrogandoci sul loro stato emotivo può migliorare la nostra capacità empatica, mentre le tecniche di meditazione possono aiutarci a controllare le nostre emozioni e mantenere un approccio più distaccato e compassionevole.
Perché questo impegno individuale verso l’empatia dia i suoi frutti, bisogna però anche creare il contesto sociale necessario. Una cosa che oggi sappiamo bene dal mondo della ricerca animale e psicologica è che lo stress riduce la nostra capacità di connessione ed empatia con gli altri. Una società iniqua, piena di disuguaglianze e di povertà, dominata da una logica performante, è una società fatta di individui stressati, in cui c’è pochissimo spazio per l’empatia. Non possiamo migliorarci e aiutarci come individui se non lo facciamo anche come collettività.
L’empatia come riconoscimento dei propri limiti
L’idea che per entrare in connessione con gli altri e aiutarli sia prima necessario provare le loro stesse emozioni, oltre che essere controproducente e dannoso, può suonare un po’ ombelicale e primitivo, visto che mette al centro di tutta l’operazione noi e nient’altro che noi, e implica che là dove non siamo in grado di provare l’emozione dell’altro, chiunque sia, siamo meno in grado di capirlo e sostenerlo.
Questo problema è solo parzialmente superato dall’idea di empatia cognitiva, ovvero della comprensione dello stato emotivo di qualcun altro senza necessariamente condividerlo. A volte infatti non siamo in grado neppure di capire con distacco gli altri, quello che provano o vogliono o ritengono giusto. Non lo capiamo perché fanno parte di una cultura diversa o perché sono in un momento della vita che ci è totalmente alieno.
In questi casi, essere empatici diventa ancora più sofisticato e complesso: implica la rinuncia di ogni comprensione, l’accettazione dei nostri limiti individuali nel capire gli altri, e in tal modo limita anche la nostra capacità di agire da protagonisti per aiutare l’altro (quando non si capisce è difficile intervenire in modo utile).
Ma ciò non ci deve impedire di ascoltare, accogliere, dare voce e accettare chi ci sta davanti. E anche questa può essere considerata una forma di empatia: non è mettersi nelle scarpe di un’altra persona, ma accettare che non lo si può fare e che l’esperienza dell’altra persona è non di meno legittima e valida quanto la nostra.
NICOLA QUADRI si occupa di comunicazione istituzionale e rapporti con la stampa presso Università Vita-Salute San Raffaele e lRCCS Ospedale San Raffaele. Ha conseguito una laurea magistrale in fisica presso l’Università degli Studi di Padova e un master in Comunicazione della Scienza presso la SISSA di Trieste. Segretario del Comitato Scientifico di BergamoScienza, ha scritto come giornalista scientifico freelance per riviste e quotidiani come La Stampa, Le Scienze e The Good Life Italia.